Artemisium News
28/05/2025
IL MONDO RURALE DI UNA VOLTA
di Mario De Capraris
La vigna richiedeva molto lavoro (la vigna è tigna, si diceva), ma in quel delle Cesine, prima che si vendemmiasse, andavamo giusto per innaffiare la preta turchina (il verderame) o per buttare lo zolfo. Rame (solfato di rame) in quantità contro la peronospora e le malattie fungine. Sconosciuta era l’anidride solforosa. Infatti il vino andava subito a male. Per il resto il solfato di rame si usava anche per la semente del grano quando si doveva seminare, e non so per quanti altri scopi veniva usato. Al momento di vendemmiare si materializzavano, non so come, i barili, che venivano trasportati col camion. In cantina invece abbondavano le damigiane e le botti. Per l’occasione bisognava pulire le botti. Per questa operazione si facevano entrare nelle botti i bambini (roba da far venire la claustrofobia) e questi raschiavano il tartaro.Le olive venivano lasciate in uno sgabuzzino del frantoio che Barbato metteva a disposizione, così sera per sera ci si ritirava con l’asino e i sacchi di olive venivano scaricati nello sgabuzzino, ma le olive che si raccoglievano erano tutto il contrario del modo in cui si raccolgono oggi, innanzitutto perché passava troppo tempo dal momento della raccolta alla molitura, subentrava l’ossidazione – infatti, che io ricordi, le olive erano nere smaturate, mentre oggi sappiamo che si devono molire verdi – e poi si raccoglievano anche a terra, che era assolutamente sbagliato. Noi ragazzi assistevamo messa in latino, senza che conoscevamo una sola parola della lingua, a Sant’Angelo mentre officiava Don Domenico Fierro. Il teatro della stessa chiesa era veramente un polo di attrazione. A vedere la commedia venivano anche le monache, tutte sorridenti e dalla compagnia piacevole. Tutto il contrario invece era il maestro della preparazione agli esami di ammissione alla scuola media, il quale difettava di modi gradevoli. A casa io non avevo giocattoli, ma non me ne lamentavo, perché ne avevo uno particolare che da solo valeva per tanti giocattoli. Avevo una pistola. Una pistola vera. Una Beretta modello 1915 brillante d’acciaio che era il mio passatempo preferito. In più avevo il caricatore e i proiettili, parte dei quali erano contenuti in un apposito cofanetto. Era l’arma di mio zio il capitano Giuseppe De Capraris, morto nella guerra del 15/18. La pistola la caricavo, ne toglievo i proiettili, li rimettevo. L’unica cosa che fortunatamente non facevo era che non sparavo. E avrei avuto a disposizione anche la sciabola appartenuta sempre allo stesso zio capitano, se non fosse che i parenti dopo la sua morte acconsentirono a metterla in mostra alla scuola elementare vicino alla chiesa di Madonna delle Grazie accanto alla sua grande foto. Era una sciabola per ufficiali modello 1888, in acciaio a tre else e impugnatura in ebano, curva. Senonché quando venne costruito il ristorante al posto della scuola, della sciabola si persero le tracce, tranne che sia conservata tuttora in qualche magazzino di una istituzione pubblica.L’estate la passavo con la famiglia in campagna, a Santu Pietro. Le campagne – almeno quelle della contrada dove stavamo noi – erano strapiene di alberi, e ogni proprietà era delimitata dalle siepi. Ogni tenuta una siepe. E la siepe non era costituita solo da piante basse, ma anche da alberi, in particolare l’olmo. E insieme c’era la cunetta, bella profonda dove spesso, nel pulirla, ci si imbatteva in qualche nido di uccelli. Ogni albero aveva il suo odore. L’olmo in particolare, del quale si raccoglievano le foglie per darle da mangiare ai conigli insieme alla “spererra” (che erano degli arbusti di vegetale, ma se mi chiedete qual è la parola in italiano non saprei che rispondere. C’erano dei termini campagnoli di cui non ho mai capito il significato, così “lu pettuosce”: si trattava di un animale selvatico ma quale sarà la parola corrispondente in italiano?). I poveri conigli avevano il loro lavoro da fare per difendersi dai topi (re ccorchje) che erano gli abitanti occulti della masseria. In quanto agli alberi, tutt’oggi è facile riconoscere l’olmo, l’olivo, la quercia, il gelso, il fico. Non vi dico che cos’era il fico. Qualcosa di un gusto speciale tra primo frutto (re vvelommera) e secondo frutto. Certe volte, per andare al paese non si faceva la strada delle “Iummarelle”, che era la strada più bassa, ma si passava dalla parte superiore della proprietà. Per questa strada si passava in mezzo a tanti di quegli alberi dove faceva fresco anche d’agosto, specialmente quando si passava per la masseria (si diceva “il casino” per significare che non era una masseria ma un fabbricato signorile) di don Michele Barbato. Da questa masseria veniva un cinguettìo di passeri fitto e ridondante, e insieme ai passeri c’era l’abbaiare continuo di un cane, che sapevamo era di colore nero.
Le sere d’inverno a volte a casa nostra, per sfuggire alla solitudine della loro strada solitaria sotto la chiesa della Madonna delle Grazie, veniva con la moglie “lu guardiaregge” (la Guardia reale) e, così, chiacchieravano con i miei, sebbene non avessero interessi comuni visto che noi eravamo contadini, E proprio su fatti accaduti nel suo mestiere che “lu guardiaregge” spesso si dilungava a raccontare. Infatti una volta raccontò che gli era stato ordinato insieme al suo commilitone di andare nel tale bosco perché un tizio si era impiccato a un albero e dovevano fare la guardia in attesa dell’autorità. Era notte quando i due arrivarono sul posto che era buio fitto. Accesero un fuoco per riscaldarsi e per avere un po’ di luce. Le ore passavano ma dell’autorità nemmeno l’ombra. Tirava vento e l’impiccato dondolava dal ramo avanti e indietro, avanti e indietro. I due, un po’ perché gli faceva senso, cercavano di non guardare in faccia il poveretto impiccato. Il quale però, a un certo punto, dopo aver tanto dondolato, si stacca il ramo e va a finire direttamente sul fuoco, sulla brace. Al che i due, con la faccia del morto che finì davanti a loro, visti gli occhi sbarrati di quello gridarono “E’ vivo. È vivo” e scapparono in preda al panico, anche se dopo, calmatisi dallo spavento, tornarono indietro. E anche adesso che lo raccontava, “lu guardiaregge” ci teneva a specificare: “Ma se l’aveste visto, altro che morto, quello mi fissò negli occhi che era assolutamente vivo. Quale morto?”
Ad agosto del 1963, quando tutto il grano era stato trebbiato e tutte le stoppie erano state bruciate, un giorno si decise di interpellare zio Giovanni per quanto riguardava la scuola che avrei dovuto frequentare in città, a Foggia. Zio Giovanni era un parente che, siccome aveva fatto la quarta (cioè la quarta elementare, che ai tempi suoi era l’ultima classe delle elementari), era considerato l’intellettuale di famiglia, visto che tutti gli altri erano analfabeti. Insomma con la cavalcatura di famiglia in un pomeriggio afoso raggiungemmo la sua masseria che si trovava a qualche chilometro di distanza e trovammo lo zio nel pieno della sua pennichella pomeridiana, che svolgeva non su un letto o giaciglio ma direttamente sul selciato davanti alla masseria, in mezzo alle galline che razzolavano. La moglie si occupò di svegliarlo e di tirarlo su, visto che, dall’aspetto cadaverico, sembrava più morto che vivo, mentre una flebile voce di benvenuto usciva dalla sua gola. E immediatamente la moglie, ben sapendo le operazioni di rito, provvide a consegnargli un fiasco di vino. E anche io sapevo – ormai l’avevo imparato – in che modo sarebbe stato preceduto l’argomento motivo della nostra visita. Per primo iniziò lo zio, che, attaccatosi al bottiglione, tirò giù delle sorsate interminabili mentre gli astanti erano in religioso silenzio e, man mano che beveva, gli tornava il colorito, si vedeva che tornava in forze, stava più dritto su se stesso. Poi, come voleva la prassi, passò il bottiglione a mio padre che, attaccandosi alla bocca del vetro e mischiando bava con bava – pulire il boccaglio sarebbe stato un atto di scortesia verso l’ospite – procedeva adesso lui alla sorsata prolungata, fatta, come da manuale, con gli occhi chiusi. E nel frattempo il discorso verteva come al solito sul raccolto, i quintali a ettaro, la vigna, le spese, le lamentele sul tempo, sulle spese eccetera. Finché si venne al dunque:“Allora” disse zio Giovanni “ho saputo che questo ragazzo vuole andare a scuola. Eh, bravo. E che scuola vorresti fare?” mi domandò dall’alto dei suoi studi.“Il liceo” azzardai io dal basso della mia ignoranza.“Il liceo?” fece lo zio, sorpreso e scandalizzato, manco avessi detto una bestemmia. “Macché liceo” disse perentorio. “Tu devi fare una scuola tecnica” sentenziò senza appello. E infatti nessuno osò contrariarlo e anzi lo ringraziammo per avere espresso un così autorevole consiglio a degli ignoranti patentati.Tempo dopo, che capitai dalle sue parti, lo stesso zio mi chiese:“Beh, allora che scuola hai fatto?”“La scuola tecnica, come mi avete consigliato. Il geometra” dissi io.“La scuola tecnica?” disse sempre sorpreso. “macché scuola tecnica. Dovevi fare il liceo.”
L’anno seguente mi trovai ad abitare con i fratelli in un pianterreno, umido e buio, nella parte vecchia della città. La sera venivano il cugino, l’amico del cugino, il cugino del cugino. E in qualsiasi ora della giornata, dalla vetrina aperta (abitudine portata in città, come si usava in paese) spesso entrava l’amico che in paese sì e no si conosceva ma che adesso, preso dalla solitudine della città, veniva a cercare compagnia. Allora avevo un amico cittadino che non faceva altro che parlarmi di pranzi. Ci raccontava spesso, a me e all’amico di Bovino con cui uscivamo insieme, che aveva mangiato il roastbeef, che senz’altro doveva essere qualcosa di buono ma né io né l’amico di Bovino sapevamo cosa fosse. Finché un giorno, sempre lo stesso amico cittadino ci invitò a pranzo a casa sua e noi pensammo chissà quale piatto nuovo e dal nome strano ci avrebbe preparato. E a tavola trovammo il bicchiere più grande e quello più piccolo, tanto che pensammo a uno spreco inutile. Però fortunatamente mangiammo gli involtini di carne, solo che alla fine l’amico-padrone di casa cercava dove avessimo lasciato il filo che avvolgeva i nostri involtini e solo allora capimmo che c’era stato un filo ad avvolgere la carne. Ma chi ci aveva fatto caso? Ce lo eravamo mangiato insieme alla carne. La domenica pomeriggio con il gruppo (e cioè Vincenzo, Antonio eccetera) andavamo a trovare lo stesso amico cittadino che abitava in una traversa di via Dante. E in cucina trovavamo il nonno, alquanto malconcio data l’età, che a malapena ci vedeva da un occhio. Questi come vedeva Vincenzo, sapendo che era un tifoso di calcio, gli chiedeva:“Vincenzo, che ha fatto il Foggia?”E Vincenzo: “Ha perso.”E il nonno, come sentiva che la squadra aveva perso, si lasciava andare a tanti di quegli improperi che quasi sembravano rivolti verso il malcapitato Vincenzo. Il quale infatti se ne lamentava. Finché quello più sveglio della compagnia gli consigliò:“E tu non dire che ha perso. Quando ti domanda che ha fatto il Foggia, digli che ha vinto.”Così la domenica successiva che andammo a trovare l’amico, il nonno come vide Vincenzo:“Vincenzo che ha fatto il Foggia?”“Ha vinto” disse subito Vincenzo.Al che il nonno, felice, fece gli apprezzamenti e anzi disse bravo a Vincenzo, manco se la “vittoria” fosse stato merito del nostro amico. E così ogni volta. E infatti il Foggia, talmente che “vinceva” che quell’anno dalla serie A fu retrocesso in serie B e chissà il nonno come rimase a chiedersi perché mai fosse successo, visto che la squadra “vinceva” sempre.
Le sere d’inverno a volte a casa nostra, per sfuggire alla solitudine della loro strada solitaria sotto la chiesa della Madonna delle Grazie, veniva con la moglie “lu guardiaregge” (la Guardia reale) e, così, chiacchieravano con i miei, sebbene non avessero interessi comuni visto che noi eravamo contadini, E proprio su fatti accaduti nel suo mestiere che “lu guardiaregge” spesso si dilungava a raccontare. Infatti una volta raccontò che gli era stato ordinato insieme al suo commilitone di andare nel tale bosco perché un tizio si era impiccato a un albero e dovevano fare la guardia in attesa dell’autorità. Era notte quando i due arrivarono sul posto che era buio fitto. Accesero un fuoco per riscaldarsi e per avere un po’ di luce. Le ore passavano ma dell’autorità nemmeno l’ombra. Tirava vento e l’impiccato dondolava dal ramo avanti e indietro, avanti e indietro. I due, un po’ perché gli faceva senso, cercavano di non guardare in faccia il poveretto impiccato. Il quale però, a un certo punto, dopo aver tanto dondolato, si stacca il ramo e va a finire direttamente sul fuoco, sulla brace. Al che i due, con la faccia del morto che finì davanti a loro, visti gli occhi sbarrati di quello gridarono “E’ vivo. È vivo” e scapparono in preda al panico, anche se dopo, calmatisi dallo spavento, tornarono indietro. E anche adesso che lo raccontava, “lu guardiaregge” ci teneva a specificare: “Ma se l’aveste visto, altro che morto, quello mi fissò negli occhi che era assolutamente vivo. Quale morto?”
Ad agosto del 1963, quando tutto il grano era stato trebbiato e tutte le stoppie erano state bruciate, un giorno si decise di interpellare zio Giovanni per quanto riguardava la scuola che avrei dovuto frequentare in città, a Foggia. Zio Giovanni era un parente che, siccome aveva fatto la quarta (cioè la quarta elementare, che ai tempi suoi era l’ultima classe delle elementari), era considerato l’intellettuale di famiglia, visto che tutti gli altri erano analfabeti. Insomma con la cavalcatura di famiglia in un pomeriggio afoso raggiungemmo la sua masseria che si trovava a qualche chilometro di distanza e trovammo lo zio nel pieno della sua pennichella pomeridiana, che svolgeva non su un letto o giaciglio ma direttamente sul selciato davanti alla masseria, in mezzo alle galline che razzolavano. La moglie si occupò di svegliarlo e di tirarlo su, visto che, dall’aspetto cadaverico, sembrava più morto che vivo, mentre una flebile voce di benvenuto usciva dalla sua gola. E immediatamente la moglie, ben sapendo le operazioni di rito, provvide a consegnargli un fiasco di vino. E anche io sapevo – ormai l’avevo imparato – in che modo sarebbe stato preceduto l’argomento motivo della nostra visita. Per primo iniziò lo zio, che, attaccatosi al bottiglione, tirò giù delle sorsate interminabili mentre gli astanti erano in religioso silenzio e, man mano che beveva, gli tornava il colorito, si vedeva che tornava in forze, stava più dritto su se stesso. Poi, come voleva la prassi, passò il bottiglione a mio padre che, attaccandosi alla bocca del vetro e mischiando bava con bava – pulire il boccaglio sarebbe stato un atto di scortesia verso l’ospite – procedeva adesso lui alla sorsata prolungata, fatta, come da manuale, con gli occhi chiusi. E nel frattempo il discorso verteva come al solito sul raccolto, i quintali a ettaro, la vigna, le spese, le lamentele sul tempo, sulle spese eccetera. Finché si venne al dunque:“Allora” disse zio Giovanni “ho saputo che questo ragazzo vuole andare a scuola. Eh, bravo. E che scuola vorresti fare?” mi domandò dall’alto dei suoi studi.“Il liceo” azzardai io dal basso della mia ignoranza.“Il liceo?” fece lo zio, sorpreso e scandalizzato, manco avessi detto una bestemmia. “Macché liceo” disse perentorio. “Tu devi fare una scuola tecnica” sentenziò senza appello. E infatti nessuno osò contrariarlo e anzi lo ringraziammo per avere espresso un così autorevole consiglio a degli ignoranti patentati.Tempo dopo, che capitai dalle sue parti, lo stesso zio mi chiese:“Beh, allora che scuola hai fatto?”“La scuola tecnica, come mi avete consigliato. Il geometra” dissi io.“La scuola tecnica?” disse sempre sorpreso. “macché scuola tecnica. Dovevi fare il liceo.”
L’anno seguente mi trovai ad abitare con i fratelli in un pianterreno, umido e buio, nella parte vecchia della città. La sera venivano il cugino, l’amico del cugino, il cugino del cugino. E in qualsiasi ora della giornata, dalla vetrina aperta (abitudine portata in città, come si usava in paese) spesso entrava l’amico che in paese sì e no si conosceva ma che adesso, preso dalla solitudine della città, veniva a cercare compagnia. Allora avevo un amico cittadino che non faceva altro che parlarmi di pranzi. Ci raccontava spesso, a me e all’amico di Bovino con cui uscivamo insieme, che aveva mangiato il roastbeef, che senz’altro doveva essere qualcosa di buono ma né io né l’amico di Bovino sapevamo cosa fosse. Finché un giorno, sempre lo stesso amico cittadino ci invitò a pranzo a casa sua e noi pensammo chissà quale piatto nuovo e dal nome strano ci avrebbe preparato. E a tavola trovammo il bicchiere più grande e quello più piccolo, tanto che pensammo a uno spreco inutile. Però fortunatamente mangiammo gli involtini di carne, solo che alla fine l’amico-padrone di casa cercava dove avessimo lasciato il filo che avvolgeva i nostri involtini e solo allora capimmo che c’era stato un filo ad avvolgere la carne. Ma chi ci aveva fatto caso? Ce lo eravamo mangiato insieme alla carne. La domenica pomeriggio con il gruppo (e cioè Vincenzo, Antonio eccetera) andavamo a trovare lo stesso amico cittadino che abitava in una traversa di via Dante. E in cucina trovavamo il nonno, alquanto malconcio data l’età, che a malapena ci vedeva da un occhio. Questi come vedeva Vincenzo, sapendo che era un tifoso di calcio, gli chiedeva:“Vincenzo, che ha fatto il Foggia?”E Vincenzo: “Ha perso.”E il nonno, come sentiva che la squadra aveva perso, si lasciava andare a tanti di quegli improperi che quasi sembravano rivolti verso il malcapitato Vincenzo. Il quale infatti se ne lamentava. Finché quello più sveglio della compagnia gli consigliò:“E tu non dire che ha perso. Quando ti domanda che ha fatto il Foggia, digli che ha vinto.”Così la domenica successiva che andammo a trovare l’amico, il nonno come vide Vincenzo:“Vincenzo che ha fatto il Foggia?”“Ha vinto” disse subito Vincenzo.Al che il nonno, felice, fece gli apprezzamenti e anzi disse bravo a Vincenzo, manco se la “vittoria” fosse stato merito del nostro amico. E così ogni volta. E infatti il Foggia, talmente che “vinceva” che quell’anno dalla serie A fu retrocesso in serie B e chissà il nonno come rimase a chiedersi perché mai fosse successo, visto che la squadra “vinceva” sempre.
Autorizzazione del Tribunale di Foggia n.20 del 20 settembre 2006
Direttore Responsabile Samantha Berardino
Direttore Responsabile Samantha Berardino
Tutto il materiale presente in questo sito è strettamente riservato - è vietato l'utilizzo dei contenuti del sito senza l'autorizzazione dei gestori. Privacy Policy | Cookie Policy







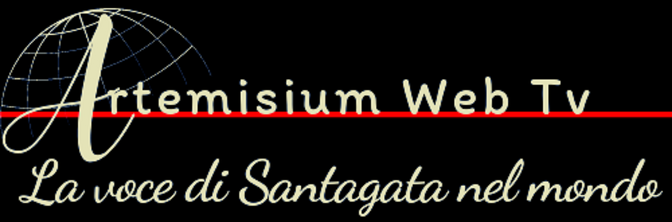






.jpg)

.jpg)


.jpg)





