Le famiglie erano talmente convinte dell’efficacia di un’usanza che non c’era modo di evitare di metterla in pratica. Questa usanza era la purga. Ai malcapitati figli veniva propinata non una purga qualsiasi, ma nientemeno che l’olio di ricino, contenuto in una bottiglietta di vetro. I ragazzi cercavano in tutti i modi di sfuggire a ingurgitare la prelibatezza, tra mille capricci e storie, ma alla fine si rassegnavano a scolarsi la bottiglietta. Riguardo la purga, la famiglia si mostrava inflessibile. L’idea di prendere un purgante alternativo non veniva nemmeno presa in considerazione perché, dicevano, non avrebbe avuto lo stesso effetto. E comunque non bastava prendere solo la purga. In più non si beveva né si mangiava durante tutta la giornata perché “l’organismo” si doveva “purificare”. Il periodo in cui si prendeva la purga avveniva in inverno. Spesso era facile incontrare qualche amico per strada anche lui intento a trattenersi mentre correva al bagno.
E d’inverno, quando era cattivo tempo, la sera, di frequente, in casa entrava qualcuno, un parente, un conoscente, un vicino di casa, che per sfuggire alla solitudine veniva a chiacchierare, spesso a raccontare episodi della sua vita. Uno di questi era “lu guardiaregge”, la guardia regia, che abitava sotto al Calvario, in una zona ventosa e solitaria.
Intanto che si raccontava, fuori pioveva o nevicava, chi lo sa. I contadini a causa del maltempo stavano in paese, così altre volte capitava di sentire altri tipi di racconti, che non ricordo per intero ma solo qualche frammento, tipo:
la processione che era andata per la campagna, nel campo di grano, e poi uno della processione aveva trovato una volpe che aveva nascosto nel grano;
del prete che era stato punto dalla civetta messa a sua insaputa nel tabernacolo;
di Cadalbenzio che a un certo momento dovette sfidare il mostro, e tutti quanti cercavano di trattenerlo perché aveva famiglia e non poteva rischiare di farsi ammazzare dal mostro e gli dicevano in coro: “Arrète Cadalbenzje ca tiéne na morra re figlje femmene. Ma Cadalbenzje…..” insomma andò a sfidare il mostro;
del sagrestano nascosto dietro il confessionale che si rivolge al fedele facendo finta che a parlare è la divinità;
di quelli che vanno in casa della vedova a portare “lu cùnzule”, cioè il pranzo che veniva offerto ai parenti del congiunto defunto (racconto che, chissà perché, divertiva in modo particolare e non si finiva mai di narrarlo).
I paesani di allora erano dissacranti. Ironizzavano su tutto, persino su avvenimenti che occorreva prendere sul serio. La società contadina si reggeva sul racconto: si lavorava, si mangiava, si stava insieme e intanto una colonna sonora faceva da sfondo, quella di raccontare. Molti racconti sono stati dimenticati, ma spaziavano da episodi relati al paese amico-nemico confinante, Accadia, i cui abitanti venivano descritti con aria canzonatoria, a quelli relativi al clero, che, rivestendo a quel tempo la sua autorità, veniva preso di mira con la satira sconfinando a volte persino nella blasfemia.
D’estate invece, anziché raccontare, succedeva che la sera in via Le Grazie, con il giovane vicino di casa che imbracciava la chitarra e riunitosi il gruppo di ragazze, non si faceva altro che cantare le canzoni del momento. E si continuava fino a tardi. Allora ci si divertiva con poco. Non c’era ancora la televisione.
Quello che non veniva mai a casa era ze Vetucce, anche se abitava nella porta affianco, più vicino al carcere. Ze Vetucce, sebbene l’atteggiamento comune era privo di tenerezze, lui al contrario era delicato, amabile e tollerante. Infatti quando noi ragazzi andavamo a casa sua (un sottano con grotta umido odoroso di vinaccia), lui era pronto a farci muovere la leva de “lu stringeture” (il torchio), che non era facile spingere perché occorreva la forza per far saltare il dente di ferro (al che si produceva il caratteristico suono). Ze Vetucce non si spazientiva mai. Nelle notti d’inverno aveva la tosse. Dalle case vicine lo si sentiva tossire tutta la notte, come si sentivano i rintocchi dell’orologio della piazza. Quando gli dicevano di andare dal medico, lui rispondeva:
“Eh lu miéreche. Adda passè.”
E infatti la tosse non passava mai.
Nicola, fratello di nonna Maria Malgieri, sarto, nato nel 1870, era emigrato negli Stati Uniti nel 1904. Abitò a Brooklyn senza mai far ritorno in Italia. Infine nel 1925 scrisse una lettera alla sorella Maria dicendosi intenzionato a venire a stare qualche giorno a Sant’Agata con la sua numerosa famiglia, ma si preoccupava se sarebbe riuscito a trovare posto almeno in un albergo. Nonna lo rassicurò che comunque avrebbe cercato di sistemarli a casa sua. E poi di alberghi ce n’erano quattro: l’albergo del Moro, del Sole, dell’Ordine e Stella Polare. Col treno Nicola sarebbe sceso a Savignano-Greci (dove avrebbe trovato la vettura) che distava da Sant’Agata 38 chilometri, e non a Foggia che distava 66 chilometri. Nicola venne al paese e lo accompagnarono a vedere tutti i posti possibili. Poi dissero che non aveva fatto altro che piangere.
Direttore Responsabile Samantha Berardino







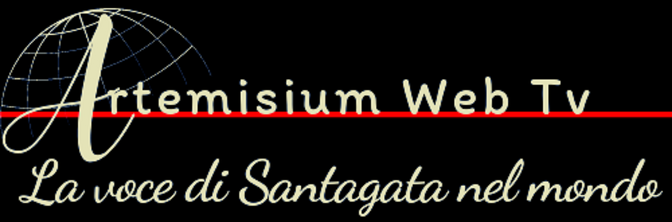






.jpg)

.jpg)


.jpg)





