Ieri che i cicli lavorativi di campieri, contadini e braccianti non potevano subire interruzioni ed il campagnolo non poteva recarsi in paese, la cappella o la chiesa rurale risolveva problemi di ordine pratico e religioso e svolgeva l'importantissimo ruolo di richiamo spirituale. Ogni chiesa una storia: storia di miseria e di ricchezze, di fame e di disperazione, di fede e di abbandono in Dio.
di Dora Donofrio Del Vecchio
Lì dove la vita dell'uomo è strettamente legata alla terra, ai ritmi stagionali e produttivi, in strettissimo rapporto con la terra è la religione, il sacro, la divinità.
Sant’Agata di Puglia, un paese del Subappennino dauno, a circa 800 m. s.l., possedeva e possiede uno dei territori più estesi della Capitanata. Un paese a chiara vocazione agraria, come tanti altri paesi del Sud, abitato in massima parte da gente dedita ai lavori dei campi, costretta a vivere per lunghi periodi dell'anno, specie quando le vie ed i mezzi di comunicazione non erano facili né a portata di mano, in campagna, in masserie o più modeste abitazioni che, in età medioevale e moderna, dignitosamente radunate in casali costituirono veri e propri comunelli rurali.
Nella struttura associativa ed economica di queste comunità, non poteva mancare la presenza di un luogo di culto. Una forte urgenza spirituale e religiosa univa “campieri” e contadini, datori di lavoro e braccianti: adempire i doveri religiosi, avere la possibilità di partecipare nei giorni di precetto alla S. Messa e frequentare i sacramenti. E poiché i cicli lavorativi, come la mietitura e la semina, non potevano subire interruzioni ed il campagnolo non poteva recarsi in paese, spesso distante anche diverse miglia, risolveva la cappella o la chiesa rurale problemi di ordine pratico e religioso e svolgeva l'importantissimo ruolo di richiamo spirituale e d'elevazione morale, offrendo nel contempo alla stessa Chiesa un mezzo di controllo di consistenti masse contadine.
Alla santità titolare del sacro luogo, anche di una semplice edicola, l'anima del contadino si apriva senza timore, e le parlava in dialetto, con un linguaggio spontaneo e confidenziale. Il rapporto con la divinità non era al di sopra né al di fuori della vita stessa del contadino, essendo essa parte della sua vicenda quotidiana e già inconsciamente presente “nelle sue scelte, nei suoi programmi e nei suoi comportamenti”. Una religiosità “più istintiva che razionale permeata spesso di superstizioni e credenze”, ma sempre genuina, autentica, profonda. Al Santo, l'uomo dei campi chiedeva protezione per sé e per i cari, per gli animali che lo aiutavano nei lavori e per il raccolto. Chiedeva tempi di pace perché fossero feconde le sue fatiche, la pioggia contro la siccità, condizioni climatiche favorevoli all'agricoltura. Egli che nulla poteva contro le catastrofi e le calamità naturali, le invasioni di formiche, topi e locuste, contro le carestie e le pestilenze, la moria di animali ed i soprusi baronali, si rinfrancava nella certezza di una protezione e giustizia divina. E dolce e ristoratrice scendeva nell'animo, con la fede, anche, e forse troppo spesso, la rassegnazione.
Numerosi furono le chiese, le cappelle, gli oratori e le edicole nelle contrade rurali santagatesi sorti in varie epoche per voto, per devozione, per consentire ai contadini di avere un luogo di culto ed uno spazio spirituale.
Di due edifici sacri fondatori o promotori sono stati due santi: S. Guglielmo da Vercelli pose la prima pietra del monastero di S. Pietro Ursitano (secondo la tradizione accreditata da fonti storiche locali), S. Giovanni Leonardi della chiesa della Madonna dell’Arco, di cui introdusse il culto a Sant’Agata.
L'istituto della cappella o chiesa rurale era di patronato laicale, come la cappella di S. Rocco; marchesale, come S. Francesco da Paola in Palino; dell’Università, come la chiesa di S. Vito.
I fondatori provvedevano a dotarle di beni per onorare degnamente il Santo titolare, quindi facevano celebrare la S. Messa e altri divini uffici, e curavano la manutenzione. Per lo stesso scopo devoti aggiungevano altre rendite. In particolari circostanze, come durante le epidemie, con il consenso del vescovo di Bovino, i corpi di coloro che morivano in campagna venivano sepolti presso le chiese rurali.
Con l’espansione dell’abitato, alcune chiese sono state inglobate nel tessuto urbano, come quelle dell’Annunziata con l’annesso convento dei Padri francescani conventuali, e di S. Maria delle Grazie con l’annesso monastero dei Padri benedettini di Montevergine. Entrambe hanno dato il nome a popolati rioni cresciuti intorno alle famiglie conventuali.
La chiesa della SS.ma Annunziata, di origine medievale, ubicata su un vallone (lu varrone) era sine cura quando, nel 1443, Francesco Orsini, signore di Sant’Agata e prefetto di Roma, volle donarla ai Frati Minori Francescani perché vi edificassero una nuova chiesa ed un convento, concedendo case, magazzini, orti, terreni di sua proprietà e prossimi alla suddetta chiesa, e quanto potesse essere necessario per la costruzione. Essa divenne, così, il primo nucleo del complesso conventuale, e ne trasmise l’intitolazione ancora oggi in uso, anche se dal ‘600 e ‘700 si disse indifferentemente “chiesa dell’Annunziata” e “chiesa di S. Antonio”, essendo divenuto molto popolare il culto per il Santo di Padova.
Anche la chiesa della Madonna delle Grazie, di cui diremo, sorse nella seconda metà del ‘500 su un’altra antica chiesa di origine medievale.
Ad alcune chiese, come per quella di S. Vito, S. Rocco, S. Giovanni, l'Annunziata, la Madonna dell'Arco, era annesso il romitorio, un istituto mantenuto da lasciti di gente pia per onorare Dio ed i Santi.
Ad eccezione delle già citate chiese di S. Maria delle Grazie e della Vergine Annunziata, di S. Maria dell'Arco, di S. Francesco da Paola, tutte le altre per varie cause (guerre, invasioni, terremoti, abbandono delle campagne), nel corso dei secoli sono scomparse. Il toponimo o qualche documento ne tiene viva la memoria. Non potendo in questa sede, per motivi di spazio, dedicare a ciascuna la trattazione che merita, ne diano un rapido cenno.
Uscendo dalla porta di S. Angelo (con Portanuova, Portella S. Andrea, Porta Lasalvia, Porta S. Nicola, era una delle cinque porte del paese) ci s’imbatteva subito nella chiesa di S. Caterina, culto introdotto certamente dai Domenicani. La Santa era titolare di un altro luogo di culto come attesta il toponimo presso Marchitellazzo-Serraiora.
Procedendo verso il Piano di S. Lorenzo, si giungeva in due chiese contigue: S. Sebastiano sulla parte superiore della strada, S. Maria della Pace sulla parte inferiore, strada che ora si denomina Viale della Pace e che porta al cimitero. Entrambe tra la fine del '500 e l'inizio del '600 furono abbattute per edificare una chiesa in onore della Madonna dell'Arco, chiesa voluta da S. Giovanni Leonardi (fondatore dell'Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio e cofondatore del Collegio Urbano di Propaganda Fide), che già aveva ricostruito a Pomigliano d’Arco la grande chiesa della Madonna dell’Arco e che nel 1596 venne a Sant’Agata per una visita apostolica al monastero benedettino di S. Maria delle Grazie, inviato da papa Clemente VIII, su consiglio di S. Filippo Neri. La chiesa aveva annesse due stanzette per il romito, e altre due (sopra) per ospitare malati contagiosi. Fu dotata di beni e cospicui lasciti dalla devota famiglia Lasalvia, cui si aggiunsero altri di altri devoti.
Poco più giù era la chiesa di S. Lorenzo e, poco distante da questa, quella di S. Toto (sorta forse su un’antichissima chiesa dedicata a S. Potito), entrambe fatte costruire dai duchi Orsini di Gravina nel secolo XV. La chiesa di S. Toto fu trasformata in residenza rurale da Giuseppe Nicola Rosati, e poi divenne proprietà dei Noviello.
La chiesa di S. Lorenzo possedeva beni che dalla contrada di Gizzoli arrivavano oltre la Pietra di S. Lorenzo (Preta re Sande Linze), e comprendevano il Ponte di S. Lorenzo (Ponde re Sande Lariènze), che cavalcava certamente il corso d’acqua che scendeva verso Gizzoli, ancora oggi detto lu varròne re Hizzele (il vallone di Gizzoli).
Dalla chiesa di S. Lorenzo, di patronato degli Orsini e poi dei marchesi Loffredo, signori di Sant’Agata, partiva il 10 agosto la cavalcata di S. Lorenzo, di cui si ha notizia dal 1462, dall’anno della presa di Accadia da parte del re Ferrante d’Aragona, cui diedero man forte proprio i cavalieri santagatesi. La cavalcata si è tenuta fino ai primi del ‘900, e con essa la fiera sul Piano di S. Lorenzo. Cavalcata e fiera (quest’ultima ancora praticata), di origini medievali, si collocano fra le più antiche della Puglia.
Il culto per S. Lorenzo è ancora vivo e molto sentito dalla comunità santagatese, che festeggia il Santo il 16 agosto, e porta la statua in processione con quelle dei compatroni S. Agata e S. Rocco.
Il sacro edificio fu abbattuto nel 1613 e sulle sue macerie sorse, a devozione di donna Eleonora Crispani (contessa di Potenza e marchesa di Sant’Agata, moglie di Carlo II Loffredo), la chiesa di S. Carlo con l'annesso convento dei Francescani riformati. L'uno e l'altro furono abbattuti (imperdonabile scempio!) nel 1963 per far posto ad un campo sportivo. Della bella chiesa si sono salvate le preziose statue lignee in massima parte seicentesche e tre altari in pietra rosea del Calaggio, custoditi nelle chiese santagatesi. In essa fu sepolto il laico frate Jacopo da Farnocchia, morto in fama di Servo di Dio; furono sepolti molti santagatesi e volle essere sepolto il marchese Carlo Loffredo, morto nel 1688.
Per la legge introdotta dai Francesi che imponeva i cimiteri fuori le mura, presso il convento dei Riformati, su un terreno dei Del Buono, si costruì il primo Camposanto e in esso la cappella che si dedicò alla Vergine Addolorata. Dal 1837 si seppellì nel Camposanto e non più nelle chiese del paese, e quella cappella è stata ed è la cappella in cui si consacra la sofferenza ed il dolore.
Tra la strada che porta ad Accadia ed il percorso che porta i pellegrini al Santuario della Madonna della Consolazione, presso la Serra di S. Vito sorgeva la chiesa di S. Vito, di patronato dell’Università, che provvedeva all’officiatura ed alla manutenzione. Una chiesa di cui ancora rimangono i ruderi (foto n.... e n....).
Nella vasta contrada di Olivola, che fu feudo marchesale, sorgeva una pieve con organizzazione politica, amministrativa e religiosa perfetta: numerose vie di comunicazione, taberna, torre di difesa e ben quattro chiese, tutte molto antiche: S. Maria, S. Pietro, S. Nicola, S. Marina.
In questa contrada s’insediarono nell'XI secolo i benedettini della SS.ma Trinità di Cava e di S. Lorenzo d'Aversa. S. Nicola era chiesa matrice, parrocchiale, con arciprete. La chiesa di S. Pietro è stata ufficiata fino alla metà dell’Ottocento. Della chiesa di S. Maria di Olivola resta una campana, la campana della speratura, che fu collocata sul campanile della chiesa di S. Nicola in Sant’Agata, e che con lenti e mesti rintocchi annunciava la morte di una persona adulta, sette rintocchi se uomo, otto se donna. Essa è custodita nel museo di detta chiesa.
Poco distante da Olivola, ma già in territorio di Accadia, un devoto di Sant’Agata fece costruire, all’inizio del ‘500, una chiesa in onore di S. Antonio da Vienna.
Dei benedettini di Montevergine (il cui ordine fu fondato da S. Guglielmo da Vercelli intorno al 1126) presenti sul territorio di Sant’Agata dalla II metà del 1100, erano la chiesa ed monastero di S. Pietro Ursitano (quest’ultimo ora proprietà della famiglia Barbato).
Fu proprio S. Gugliemo da Vercelli a porre la prima pietra del monastero di S. Pietro Ursitano, voluto da Ioele, figlio di Ralnolfo Brittone, signore normanno di Sant’Agata, il quale fu generoso nella dotazione di beni, ed assegnò a detto monastero oltre alla chiesa di S. Pietro Ursitano, rurale, quella di S. Maria delle Grazie, sul Serrone, extra moenia, a sud-est dell’abitato. I monaci benedettini accanto a questa chiesa, che ricostruirono, costruirono il monastero, che ancora si ammira, e vi si trasferirono nel 1580.
Presso il Ponte Romano di Palino e su un'importante arteria viaria, la Via beneventana, era la chiesa di S. Antonio Abate(Sandanduòne), con convento, taberna e dogana delle pecore. Manca una documentazione che faccia sufficiente luce sulla sua storia. Ma da quella a disposizione sappiamo che era stazione viaria al tempo dei romani, che il convento ospitò una fraternità Antoniana e forse i cavalieri di Malta, che fu una fiorente masseria al tempo di Federico II. Era feudo degli Orsini, poi dei marchesi Loffredo.
Popolo e clero santagatesi vi si recavano processionalmente due volte l’anno, il 17 gennaio per benedire campagne ed animali, e la seconda domenica di maggio, in ricorrenza della fiera che si teneva nel cortile del convento. Il marchese offriva elemosine ai bisognosi.
Poco distante, nella masseria di Palino (che fu visitata nel maggio del 1797 dal re Ferdinando IV di Borbone, il quale ne ammirò l’organizzazione), era l’oratorio rurale senza asilo di S. Francesco da Paola, fatto costruire nel 1723 dai marchesi Loffredo.
Nella contrada sotto al cimitero sorgeva la cappella di S. Anastasia (S. Stèse), che ha lasciato il nome alla contrada.
Sotto il serro su cui sorge la chiesa di S. Rocco, era ubicata l'abbazia di S. Giovanni Battista. Resta il nome alla Fontana detta di S. Giovanni.
Anche Casaliandra, Casalicchio e Bastia, popolosi antichi casali, ebbero certamente il loro luogo di culto, ma i documenti finora consultati non ne fanno sicura menzione. Alla Bastia sorgeva un “conventuolo”.
A Borgineto era ubicata una cappella dedicata a S. Lucia, la vergine martire siciliana molto venerata a Sant’Agata.
Il culto dell’Arcangelo è confermato dal toponimo Sand’Arcangele (Sant’Arcangelo), una collinetta sulla cui cima la tradizione religiosa santagatese vuole si sia posato l’Arcangelo Michele, cui è dedicata la chiesa parrocchiale più antica di Sant’Agata, quella di S. Michele.
Di due altri possibili luoghi di culto, S. Abbondio e S. Marciale, di cui si ha notizia da qualche documento, data la scarsezza dei dati, non è possibile indicare l’ubicazione.
In seguito alla terribile pestilenza del 1656, a devozione dell’intera popolazione sorse la chiesa di S. Rocco, extra moenia, poco distante dalla Chiesa matrice di S. Nicola, su uno sperone della collina sotto il castello. Era officiata da un rettore. Un laico ne aveva cura, ed aveva cura anche del “porcellino” che i devoti offrivano al Santo il giorno della sua festa. Esso girava libero per il paese tutti i giorni dell’anno, alimentato per devozione dalle famiglie e ritenuto quasi sacro e degno di grande riguardo. A tempo giusto il maiale veniva macellato ed il ricavato dalla vendita delle carni utilizzato per la festa del Santo.
Alla chiesa di S. Rocco non era annesso il romitorio, però un devoto aveva cura della chiesa e del maialino. Spesso lo portava con sé quando girava per le strade del paese per elemosinare.
A questo grande Santo il popolo dedicava una forte devozione ed una festa organizzata dai “campieri” che prevedeva, oltre alle cerimonie religiose, giochi e gare di abilità, tra cui quella del “solco di San Rocco” e della presentazione del “carro di covone”.
Il primo coinvolgeva gli aratori: bisognava tirare un solco diritto dalla località “Puzze re miézze carre” di Palino fino alla chiesa di S. Rocco. Cosa non facile considerata la distanza e le asperità del luogo, gara di abilità praticata già dalla fine del ‘700. Una commissione di periti valutava la dirittura dei solchi.
L’altra gara, praticata fino ai primi del ‘900, consisteva nel raggiungere, percorrendo i non facili sentieri di campagna, la cappella del Santo nel minor tempo possibile con un carro carico di covoni di grano trainato da buoi, covoni che si offrivano al Santo.
Un altro luogo di forte richiamo spirituale è la cima del Monte (alt. mt. 716) di fronte al paese, ove l’8 giugno 1901 si collocò la monumentale Croce di ferro fuso, espressione della costante e forte devozione di santagatesi per la Croce ed il Crocifisso. La chiesa santagatese rispose all’appello di papa Leone XIII, che riproponeva l’antico culto della Croce, e faceva installare 19 Croci su altrettanti monti scelti in tutta l’Italia in ricordo dei 19 secoli della nascita di Cristo e, quindi, della redenzione per gli uomini. Il 3 maggio di ogni anno, festa dell’Invenzione della Santa Croce, devoti si recano a pregare ai piedi di quel sacro simbolo, su quel monte che da oltre un secolo si chiama Monte della Croce. Il 14 settembre, festa della Esaltazione della Santa Croce, si va processionalmente, vi si celebra la santa messa e si distribuiscono crocifissi ai devoti a cura del Comitato “Amor Crucis” costituito nella Parrocchia di S. Nicola. Dal 14 settembre 1991 la monumentale Croce è costantemente illuminata, ed una lapide lo attesta con questa iscrizione: “Alla Croce di Cristo/Simbolo di fede/Faro di civiltà/Dedichiamo /Questa illuminazione /Permanente/Il Comitato “Amor Crucis”/Fedeli, Autorità civili e religiose/14 Settembre 1991”[1].
Chiese e cappelle in campagna non ne sono state più costruite, anche per l’abbandono da parte dei contadini della stessa campagna. Ma sono sorte edicole alla Bastia (Madonna dell’Incoronata), sulla strada che porta ad Accadia, presso il campo sportivo (S. Michele Arcangelo, dal devoto Volpone Alessandro), sulla strada che dal Perillo porta al cimitero (Vergine Incoronata, S. Pio), sulla strada che da S. Rocco porta alla Casa del S. Cuore (S. Pio).
E sullo spianato del seicentesco tempietto dedicato a S. Rocco, in un suggestivo quadro ambientale e paesaggistico, una sosta. Rivediamo dall'alto l'immenso panorama circostante e con uno sguardo d'insieme abbracciamo i luoghi del sacro. Tanti sentimenti, interrogativi, riflessioni ci portano alla qualità della vita dei nostri antenati ed alla loro religiosità. Ogni chiesa una storia: storia di miseria e di ricchezze, di fame e di disperazione, di fede e di abbandono in Dio.
Tante microstorie utili a comporre il tessuto sociale, politico ed economico della comunità. Tante chiavi di lettura per comprendere la valenza di determinate scelte devozionali e cultuali da parte di uomini di potere e di povera gente.
Così, tra una riflessione e l'altra scorrono davanti ai nostri occhi riposanti visioni di linde chiesette dai pavimenti erbosi e dagli altari adorni di fiori campestri, il cui profumo si mesce a quello degli incensi. E dalle numerose valli intorno, a primavera coppe di smeraldo, sembrano levarsi ancora voci argentine di campanelle che chiamano al culto, cui fanno eco accorate salmodie e ritmiche cantilene contadine.
Terminavo di scrivere questa ricerca, 25 anni fa, quando mi veniva comunicato che mia nonna,
Francesca Schiavone, cessava di vivere. La dedicai e la dedico a lei, con amore senza fine.
Dora Donofrio Del Vecchio
Direttore Responsabile Samantha Berardino







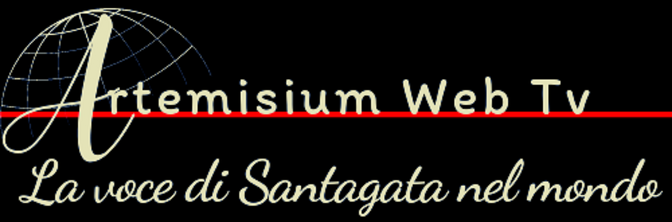






.jpg)

.jpg)


.jpg)

.jpg)



