Che io ricordi, Sant’Agata era il paese dei diminutivi e vezzeggiativi. Al bambino non si faceva in tempo a dargli un nome che già glielo cambiavano. Antonio – Anduniucce, Antonia – Andunetta, Vito – Vetucce, Agata – Ahatina, Eleonora – Nurecchia, Raffaele – Feluzze, Angelo – Angelicchje, Leonardo – Narducce, Carmela – Carmalina, Michele – Mecheline e così via dicendo.
Ma era anche il paese che andare dal medico era l’ultimo dei pensieri. Se ci si ammalava non si prendevano medicine, a parte il fatto che era raro che uno, per esempio, prendesse l’influenza. Una volta comare Rosina era passata per il terreno di compare Rocco e si era sentita male. La cosa l’aveva fatta preoccupare e per questo non era andata dal medico, ma, certa della causa del suo malanno, la sera si recò a casa di compare Rocco che si era appena ritirato dalla campagna. La comare gli riferì come effettivamente erano andati i fatti e cioè che si era trovata a passare per il suo terreno (“che ci siamo pure salutati, ti ricordi?”) e nello stesso istante si era sentita male. Sul momento non ci aveva dato peso, ma, siccome più passava tempo e più si sentiva male, si era detta: “Questo non puo’ essere stato che compare Rocco” ed era per questo che si era precipitata a casa sua, perché l’unico che poteva toglierle quel maleficio era lo stesso che l’aveva scagliato e cioè compare Rocco. Il poveretto, in colpa come se avesse pugnalato una persona alle spalle e mezzo trasecolato per avere prodotto senza saperlo un tale danno, si affrettò a dire che mai si sarebbe sognato di farle del male e se ciò era avvenuto era dovuto evidentemente ad un puro caso che non aveva nulla a che fare con lui. Tuttavia, dietro le insistenze della comare, si adoperò in tutti i modi ad augurarle ogni bene e che stesse sempre in salute. Infatti la comare ebbe già a sentirsi meglio.
Prima dell’avvento della televisione nelle case, le sere si passavano in piazza o nei circoli, ma nelle lunghe serate invernali – che era cattivo tempo e si era liberi dai lavori in campagna – spesso c’era quello che andava a trovare i parenti (rigorosamente da solo perché marito e moglie non uscivano mai insieme). Costui faceva cenno di voler entrare – la porta al solito, come in tutte le case, era solo appannata – ma era già a disagio prima di entrare. Succedeva che trovava la famiglia a tavola, allora mostrava di non voler disturbare, in modo che quelli di dentro si davano da fare a incitarlo a entrare e infine l’ospite (Michelino) entrava, ma sembrava che lo faceva solo per accontentare i padroni di casa, che, se fosse stato per lui, non sarebbe entrato. E, come per giustificarsi, Michelino diceva:
“Passavo di qua e allora mi sono detto: vediamo che fa Vituccio.” Invece era sceso apposta da lu Castierre a lu Carcere. “Mo’ vuje stète mangianne…”
“Mangianne? È ra mo’ che hamme fernute. Mé, triése, mica vuje rumanì sopa a la porta?”
Infine Michelino entrava, ma non si sedeva assolutamente, e sempre stando in piedi chiacchierava chiacchierava, e di tanto in tanto mostrava di volersi congedare perché si avvicinava alla porta quando il discorso sembrava esaurito. Ma poi tutt’assieme il ragionamento prendeva forza e l’ospite riguadagnava il centro dello stanzone. Così per tante volte. Non che il discorso contenesse argomenti degni di nota, anzi spesso si avvitava su se stesso, ma il modo di esporre continuo, l’eloquio abbondante e prolisso esercitava un suo magnetismo, anche perché esisteva tutta quella dinamica, quella scena: Michelino che era entrato all’apparenza “perché si era trovato a passare”, il fatto che mostrasse ogni tanto di voler andare via, il suo rimanere doverosamente in piedi nonostante gli inviti a sedersi, insomma un modo di fare precario come era precario e privo di comodità tutto lo stile di vita dei contadini di allora, a cominciare dal loro modo di sedersi (il sedere poggiato sull’estremità della sedia) per finire al loro pisolino pomeridiano fatto direttamente per terra sull’aia, con le galline che ci passavano sopra. In ambito sociale, per stare bene, avevano bisogno che tutto fosse poco impegnativo. Quando dovevano affrontare una festa, una cerimonia e si vestivano con l’abito (diciamo) buono, sembravano dei manichini. Soffrivano come se li avessero imprigionati in una corazza. Stavano bene solo quando vestivano i soliti stracci.
Ma tornando a Michelino, lui parlava e quelli, che ascoltavano – vuoi la stanchezza, l’ora tarda, la cantilena delle chiacchiere – un po’ “capuzziàvene”, cioè venivano presi da improvvisi colpi di sonno che facevano pendere per un istante la testa, al che l’ospite, come se avesse avuto un’improvvisa intuizione:
“Ma vuje tenite suonne.”
E quelli, riprendendosi: “Suonne? Eh, ce ne vole pe pegliè suonne.”
Era evidente che quelli non ce la facevano più. Non ce la faceva più neanche l’asina dalla grotta che a un certo punto faceva sentire la sua voce, come per dire:
“Basta adesso. Vattene a dormire. Ma ce l’hai una casa?”
Michelino alla fine se ne andava e i padroni di casa, qualcuno senza nemmeno spogliarsi, si andavano a buttare direttamente sul letto e incominciavano subito a russare.
Direttore Responsabile Samantha Berardino







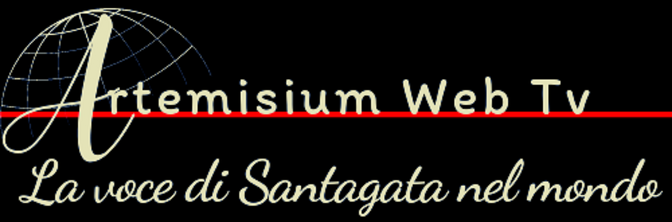






.jpg)

.jpg)


.jpg)






