Uàn dollar”. Zio Franco me lo dava in occasione delle feste. Era stato in America, manovale, e ancora conservava qualche contatto, di cui però non parlava. Io non facevo domande: ero contento del regalo, niente di importante, neanche nei tardi anni ’40 e inizio ’50. Davo il dollaro a mio padre che me lo cambiava. Allora il cambio, fisso per tanto tempo sui 624,50 - massimo 624,80 - era detto alla radio come una notizia importante. E lo era, per tante famiglie che pensavano allo zio d’America. Io lo zio d’America lo avevo a casa di mia zia Gina e non era davvero un Paperone. Anzi, non era nemmeno mio zio. A regola era il marito della sorella di mia nonna, che aveva fatto da madre alla mia. Zia Gina era la seconda moglie di Franco. L’altra, dalla quale aveva avuto un figlio, era morta.
La prima moglie aveva utilizzato i soldi, intestando tutto al figlio Pasquale. Quando era tornato, Franco aveva scoperto di non aver nulla di suo. Dell’America gli restavano ricordi che non spartiva con nessuno: al massimo diceva di aver faticato come una bestia. Gli restava il vezzo di firmare i suoi bigliettini, con cui accompagnava il dollaro quando non me lo consegnava personalmente, con il nome “Frank”. E ogni tanto gli scappava di essere stato a “San Francisco”. Era di Sant’Agata di Puglia, in provincia di Foggia. Con mia zia Gina, andava e non andava d’accordo: lei, veneziana, lo aggrediva: “ maedéti, che i vien da quée crode” (da quelle grotte). Ma si tenevano compagnia
da vecchietti. Durante la guerra, avevano nascosto un uomo politico antifascista che poi sarebbe diventato un importante ministro, che, mi dicevano, riconoscente, aiutò la carriera in Polizia di Pasquale. Il quale aiutava a suo modo il padre: un locale notturno del centro di Roma gli dava dei foglietti di pubblicità da distribuire. Così, a volte, accompagnavo il vecchio ex manovale nei suoi giri per distribuire le réclame. Lui non si sentiva offeso. Io ero contento di andare un po’ in giro.
Una volta mi regalò un paio di pantaloni di tela blu arrivati dall’America. Avevo 10 anni. Era il 1951 e facevo la quinta elementare. Mi facevano proprio comodo quei pantaloni e, arrotolando il fondo - erano un po’ lunghi - mi sarebbero andati bene per qualche tempo. A scuola la maestra mi accolse severa: “Cosa ti sei messo? Carnevale è finito. Non siamo mica in un film di cow boy”. A quel tempo i blue jeans erano praticamente sconosciuti.
Il registro di bordo della nave “Conte Rosso”, partita da Napoli e arrivata a New York il 5 agosto 1922, dice che
Francesco, zio Franco, 37 anni, originario del sud Italia - già, perché gli americani distinguevano, e solo per l’Italia, se
uno veniva dal Nord o dal Sud - era trader, commerciante, sposato con Caterina, anche lei di Sant’Agata di Puglia,
ed era diretto a Bayonne, nello stato di New York, presso il cognato, Luigi, che abitava al 473 della East Avenue. A
bordo c’erano anche altri due compaesani di Sant’Agata, ma diretti verso altre località. I casi della vita: in fondo alla
stessa pagina del registro della nave, tre calabresi di Diamante, contadini, vanno anch’essi da loro parenti. Sono sposati anche loro con delle compaesane. Due delle tre mogli si chiamano Sollazzo, una Carmela e l’altra
Filomena. Anche mia moglie si chiama Sollazzo. Anche lei è originaria di Diamante. Insomma, io e mia moglie stiamo insieme dall’agosto del 1922. E da allora ci vogliamo bene.
Anche il nonno di mia moglie, Gaetano, era emigrato, ma a Santo Domingo. Aveva fatto i soldi sufficienti, quando era
rientrato, per comprare un pezzetto di terra, una casa e far studiare il più vecchio dei figli maschi, mio suocero.
Quando morì mia zia Gina, in una casa di riposo dove era stata da poco ricoverata con il marito, Franco rimase solo. Pasquale (“Pasqualino” era arrivato ad essere questore) se lo prese a casa.
Noi ci sentimmo sempre più raramente, perché mia madre non era in buoni rapporti con il figlio di zio Franco (e viceversa).
Poi il silenzio. Quando ne parlavo con mia madre, lei diceva: “ormai dev’essere morto”.
Nel 1985, ero in Puglia per un réportage sulla siccità del Sud. Ero in una piatta campagna a sud di Foggia, in mezzo ad un campo di grano, parlando con un agricoltore. In fondo, paesini arrampicati sulle colline. Uno davanti agli altri. Domandai come si chiamasse. “Sant’Agata di Puglia”, rispose l’uomo. “Mio zio viene da lì”, dissi pensoso. Come si chiamava? Glielo dissi>
“Eh… è morto”. Lo seppi così.
di Fausto Spegni
Questa bella storia l'ho trovata navigando in internet a me è piaciuta ho piacere di condividerla con Voi
Direttore Responsabile Samantha Berardino







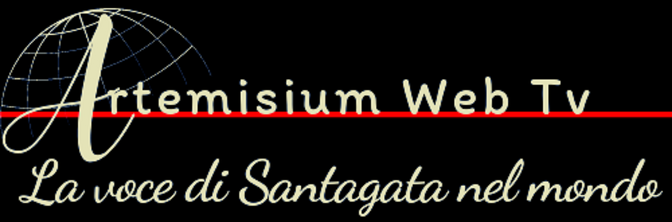






.jpg)

.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)



