La dolce poesia del maestro Castello sulla chètecatascia ci riporta alla bellezza del nostro dialetto.
Se non ricordo male, Gino Marchitelli narrava che l'idea del “Vocabolario” gli venne per reazione a quello che aveva affermato un suo maestro, secondo il quale il nostro dialetto era talmente difficile che era impossibile metterlo per iscritto; le parole avevano una tale complessità fonetica che era preclusa qualsiasi trascrizione. I fatti poi gli avrebbero dato ragione, come sappiamo.
Ma, a distanza di tanti anni, stupisce la immutata originalità delle parole, specialmente quelle che risultano lavate solo nello Speca e nel Frugno.
Non so, prendete per esempio: matafòne, cuòfene, mappina, tazzechè, zoca, li zìrpele, zerpulènde, zenzeluse, zènna, zuculèrra, zumbè, tòtela, 'nghiummète, 'ngine. (Spero di averle scritte bene) Queste parole sono completamente diverse da quelle corrispondenti in italiano.
Il dialetto è bello ma è come un monumento, da preservare e da ammirare ogni tanto. Non da servirsene: sarebbe come utilizzare la Cappella Sistina per varie funzioni, mentre l'unica funzione è quella di essere ammirata.
Per questo i compaesani che, pur trovandosi in altre città, parlavano il nostro dialetto, non preoccupandosi che gli altri li comprendessero, si capiva che avevano i loro buoni motivi, o che lo facevano per necessità non potendo padroneggiare la lingua nazionale o che volevano affermare con orgoglio che il proprio dialetto non aveva niente di meno rispetto a qualsiasi altra lingua.
Ma ci fu un episodio che mi ha portato ad essere ancora più convinto del monumento che è il dialetto, e questo accadde molto tempo fa quando una sera, uscendo con Tonino, si unirono alla compagnia due universitari della provincia di Bari che studiavano a Roma.
Quella sera andammo a mangiare a un locale alle spalle della Fontana di Trevi, dove servivano cibi austriaci, infatti tra l'altro mangiammo crauti e wurstel.
E durante la cena e poi passeggiando, Tonino come al solito parlò solo in santagatese e anche gli universitari si espressero per tutto il tempo nella loro lingua terribile e impossibile a comprendersi. Non so come Tonino e quegli altri si capissero, ma a un certo punto non ne potevo più e mi venne in mente il Manzoni che giustamente voleva risiedere per un po' a Firenze per sciacquare la sua lingua nell'Arno.
Quelli stavano a Roma e non avevano sciacquato almeno nel Tevere manco un avverbio.
Capii che difficilmente, anche trovandomi con un compaesano, avrei mai parlato in dialetto.
A fine serata mi avevano riempito la testa delle loro espressioni dialettali di cui, a parte il parlare di Tonino, non avevo capito un'acca. Pensavo:
“E meno male che siamo corregionali. Figuriamoci se capitava uno di Aosta.”
Però anche Tonino a volte si rendeva conto del problema perchè spesso era costretto a tradursi quando per esempio diceva “uagnarda” perchè gli altri subito si bloccavano: “La uagnarda? E che cos'è?”
Direttore Responsabile Samantha Berardino







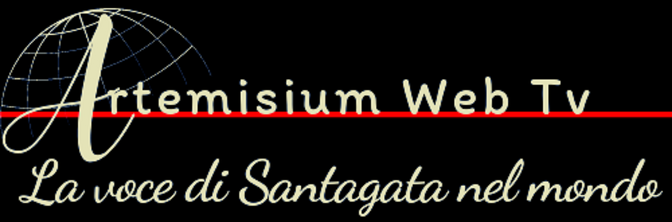






.jpg)

.jpg)


.jpg)





