Mio padre si chiamava Vituccio (Vito). Gli era stato imposto questo nome per una grazia ricevuta da San Vito, Santo protettore della rabbia, un male allora che era facile contrarre a causa della vicinanza degli animali. La rabbia anche detta idrofobia, cioè paura dell'acqua, perchè tra l'altro i dolori alla gola sono talmente forti che si ha paura di ingerire persino l'acqua. Passò la vita in parte a Li Trìsciti vicino Lime Muorte (contrade che non conosco) in parte a San Pietro Ursitano.
Da giovane, piccolo agricoltore del suo pezzo di terreno, era solito impiegare manodopera nei lavori di campagna quando ancora gli operai costavano poco e lui aveva finanze sufficienti che glielo permettevano. Però, più avanti negli anni, si trovò senza più la possibilità di utilizzare manodopera e dovette fare il coltivatore di grano, ma era evidente che si trovava più a suo agio come ortolano e vignaiuolo, attività da cui non si ricavava un soldo bucato. Il grano, oltre ad essere più impegnativo dal punto di vista fisico, non gli risultava interessante come potare o innestare, saperi che andarono perduti perchè i figli presero altre strade. Lui aveva il gusto della pianta dell'uva particolare, della frutta speciale, delle tecniche di impianto, la vite americana più resistente alla peronospora, il canestro da impagliare con i rami freschi del salice. Quando era nell'orto si vedeva che lì si realizzava, nel cogliere e decantare la bontà dei gustosi meloni gialli mentre ne tagliava le fette, o nell'innaffiare al calare del sole sotto i maestosi mandorli e i fichi. I due alberi con cui si faceva la prelibatezza dei fichi secchi con la mandorla tostata all'interno.
Preso nel suo mondo rurale, Vituccio era fatto di un'ingenuità contadina per cui credeva di saper conoscere gli uomini come conosceva i terreni.
Era il terz'ultimo di non so quanti figli, per la maggior parte morti in tenera età. Quando poi morirono anche i fratelli Giuseppe e Leonardo nella prima guerra mondiale e Angiolina per malattia a diciotto anni, gli ultimi tre fratelli rimasti vivi si convinsero che il destino era segnato anche per loro e di lì a poco sarebbe arrivato il momento di morire. Secondo la mentalità di allora, facevano risalire la causa di ciò che ritenevano una maledizione a un lontano antenato che aveva dato grano a credito con tassi da usuraio. Così decisero di non sposarsi, tranne che poi in seguito due ci ripensarono.
Nella casa di via Le Grazie, sia per il mobilio che era rimasto della famiglia precedente, sia per i documenti e fotografie, era impossibile non pensare alle persone che ci avevano abitato. In particolare in uno stanzino vi erano la libreria e una cassapanca zeppa di libri. Scoperchiare quella cassapanca era come aprire un magico contenitore carico di meraviglie. I libri erano tutti di uno zio che viveva lontano. I volumi erano un'infinità, tutti romanzi, i più numerosi quelli di Ponson du Terrail, un autore francese, romanzi giallo-polizieschi dagli interminabili dialoghi e dagli intrecci precisi di trame complicate dai titoli come “La corda dell'impiccato” o “La baronessa defunta”, libri che alcune estati mi tenevano impegnato in campagna mentre i mietitori ogni tanto mi richiamavano al dovere di portare un secchio d'acqua o il fiasco di vino. Ma ricordo anche tanti giornali come “Excelsior” e “Il travaso delle idee”.
I contadini, che per tutto l'anno avevano la dimora fissa in campagna, nel periodo di Natale tornavano in paese. Però non sopportavano le feste. Queste li deprimevano. Giravano per casa come in una gabbia, erano insofferenti, non sapevano che fare. Non esistono individui così sensibili all'ambiente come i contadini. Fuori del loro terreno erano come pesci fuor d'acqua. Abituati in campagna a non stare mai con le mani in mano – sempre indaffarati come solo i contadini sono capaci – nel trovarsi in paese, dove bisognava oziare per di più in quattro mura, non vedevano l'ora che le feste finissero per tornare in campagna. Non provavano altro divertimento che non fosse la solita routine di campagna. Rifuggivano gli agi(?) che offriva il paese perchè li consideravano dannosi e ingannevoli, cioè predisponevano secondo loro a una vita facile non realmente possibile. Inoltre erano a disagio per dover vestire gli indumenti delle feste, puzzolenti di naftalina tenuti chiusi inutilizzati per anni nell'armadio, che non erano i belli comodi sporchi stracci della campagna. Sentivano la necessità di ritornare alle sane scomode abitudini come la sera stare nella masseria priva di elettricità con l'unica illuminazione fornita dal focolare o andare al bagno all'aria aperta, prendere l'acqua dal pozzo anche se si gelava, andare nella stalla e essere accolti dal verso riconoscente del mulo al quale si portava l'avena, povera bestia che ruminava solitaria nel buio.
Fintanto che stavano in paese, la sera, davanti al camino dove la legna bruciava scoppiettando, i contadini raccontavano le storie e allora tutti prestavano ascolto, anche le donne che, padrone nelle case, durante il giorno li avevano rimproverati per bene: “E llèvete ra nanze. Stèje sembe mmiézze a li piere”.
Però più che le storie c'era qualcosa che da ragazzi si aspettava con impazienza, qualcosa senza valore e all'apparenza nient'affatto importante: una cartolina. Era la cartolina di Natale che ogni anno si riceveva dalla zia che abitava a Rionero. Questo paese ce lo immaginavamo perso tra le montagne, coperto di neve, irraggiungibile e distante una enormità di chilometri. Sulla cartolina di regola erano raffigurati tre bambini sotto un cielo di neve – due maschietti e una femminuccia – che dovevano rappresentare noi fratelli in diverso ordine di età così come eravamo nella realtà. Quella cartolina ce la giravamo tra le mani perchè piaceva immedesimarci in quelle creature da favola così ben vestite e pulite dai bellissimi visi, le bellissime giacche colorate, le bellissime scarpe, creature che dovevano abitare in un mondo fantastico prescluso a noi mortali.
“Buon Natale. Mando una carezza piena di affetto ai bimbi. Vi voglio bene” scriveva la zia sulla cartolina, inusuali espressioni affettuose che avevano un loro effetto in un ambiente in genere refrattario alle effusioni, allo stesso modo delle figure della cartolina che ci tiravano fuori dalla realtà per consegnarci un mondo incantato fatto di sentimenti positivi.
In una realtà priva di movida, di musica e televisione, nei giorni che precedevano il Natale però era fantastico il canto da cui si veniva sorpresi a volte nelle chiese, avvolti dall'odore acre dell'incenso. “Tu scendi dalle stelle” o “Bambinello bello bello” venivano cantati senza l'accompagnamento di nessuno strumento musicale, ma già il canto era una musica.
Direttore Responsabile Samantha Berardino







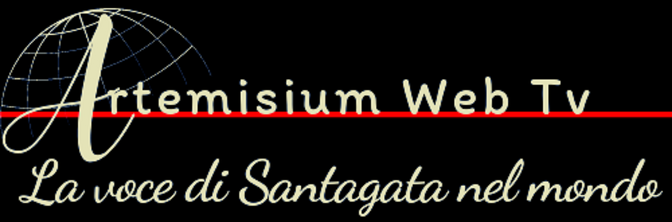






.jpg)

.jpg)


.jpg)





